|
L'intervista
a
Federica
Muzzarelli
nasce
dalla
visione e lettura di
tre
volumi sulla fotografia
realizzata
dalle donne
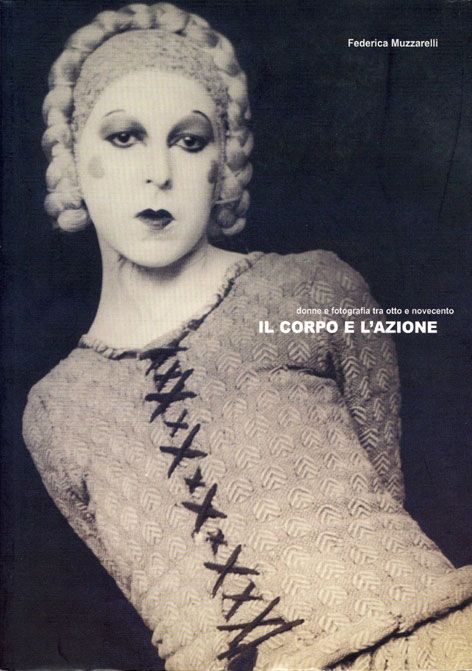

FEDERICA
MUZZARELLI
IL
CORPO E L’AZIONE
Donne
e fotografia
tra
otto e novecento
Editrice
Atlante
www.atlantelibri.com
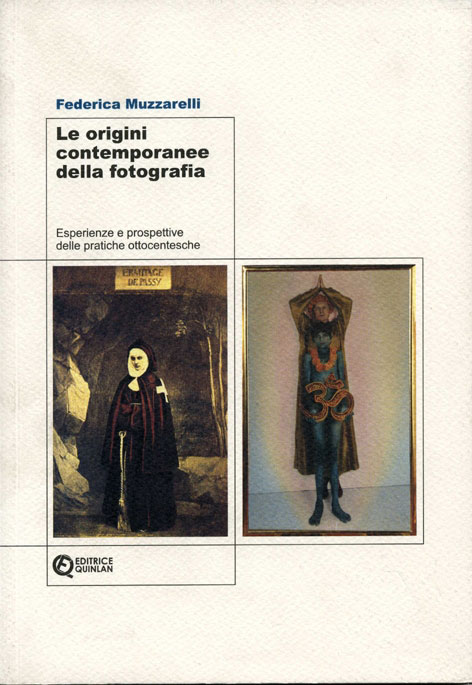

FEDERICA MUZZARELLI
Esperienze
e prospettive
delle pratiche ottocentesche
Editrice
Quinlan
www.aroundphotography.com
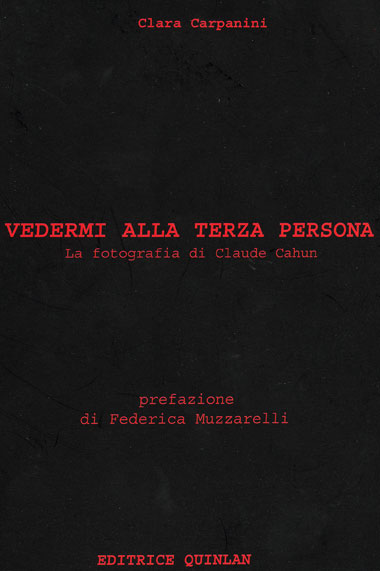

CLARA
CARPANINI
VEDERMI
ALLA TERZA PERSONA
La
fotografia di Claude Cahun
Prefazione
di Federica Muzzarelli
Editrice
Quinlan – www.aroundphotography.com
|
Teresa
Bianchi - Nel volume “il corpo e l’azione”propone il lavoro di dodici fotografe
che, nella loro produzione, si sono “ritratte” e hanno “fotografato” intimamente tutto ciò che
circondava il loro mondo, in modo crudo e creativo, a differenza della
fotografia maschile a volte più sofisticata, quale è stato l’imput sulla
scelta delle artiste, ad esempio non ha parlato di Gisèle Freund o Lotte
Jacobi, forse è in programma un altro volume.
Federica Muzzarelli - La domanda
che lei mi rivolge mi è stata fatta, e giustamente, molte volte. Sia nel
merito delle "esclusioni" sia in quello di un possibile
"secondo tempo" della pubblicazione sulle donne e la fotografia.
Le rispondo dunque separatamente. Se guardiamo al panorama della pratica
fotografica delle donne nel
periodo da me preso in esame (dalle origini alla seconda guerra mondiale
circa), molte sono le personalità e le esperienze che meriterebbero grande
attenzione e rivalutazione e che ancora oggi sono poco conosciute se non nel
ristretto campo dei gender studies. Detto questo ci sono poi donne fotografe,
come Jacobi o Freund o potremmo aggiungere Bourke-White o
Lange ecc., già
molto note che però io non approfondisco o cito solo marginalmente.
A questa doppia situazione c'è una medesima spiegazione. La mia intenzione
non era quella di pretendere di riscrivere una storia della fotografia che
includesse finalmente tutte le figure delle donne escluse, il testo non
è un'antologia né appunto una storia. è un saggio critico che propone
un punto di vista e un metodo d'analisi molto chiaro volto a sostenere che nella fotografia di alcune
donne, dalla vita anche molto particolare, si mette in azione una
dimensione concettuale dell'uso dello strumento fotografico che i
contemporanei (uomini) ancora non sono in grado di percepire.
Questo non per caso, ma in quanto la cultura, la filosofia, l'arte,
l'estetica, la società si stavano avviando ad una fase rivoluzionaria che,
seppur non completamente e con grandi difficoltà, avrebbe riportato al
centro dei dibattiti le esigenze del corpo, dell'interazione con
l'ambiente, dell'esperienza percettiva e, infine, tutte queste cose insieme,
delle donne.
Sulla seconda questione, il progettare una seconda parte del libro, le risponderei
che si potrebbe anche fare. Sarebbe però una cosa diversa proprio sulla
base della tesi sostenuta qui sopra: dagli anni delle
neoavanguardie a oggi è certo che le donne occupano nell'arte sempre più
spazi e importanza. Ma quella fase eroica, complicata e affascinante,
piena di speranze e gonfia di delusioni, quella cioè analizzata ne Il Corpo e
l'Azione, ha caratteristiche sue e irripetibili, nella sostanza e nell'ipotesi
critica che propongo.
T.B. - Nel volume “Le Origini Contemporanee
della Fotografia”, sempre realizzato da lei, ha rivisitato la storia dalle origini ai giorni nostri. Ha aperto un
“Vaso di Pandora”, tutto era già scritto o no?
F.M. - Da un punto di vista schiettamente filologico e storico certo tanto è stato
scritto sulle vicende originarie della fotografia, anche se credo che
amici come Italo Zannier dimostrino che c'è sempre ancora tanto da fare per chi indaga e studia con passione. In questo caso, della pubblicazione
"Le origini contemporanee della fotografia", la mia idea era
anzitutto fare i conti con una preparazione universitaria spezzettata che
ci obbliga a fornire agli studenti strumenti sintetici e agili. Non
piacerà, a me non piace, ma è così e ci si deve confrontare con
questo. Nel farlo però ho creduto di non scrivere un
"bignami" di storia della fotografia, ovvero semplicemente una
sintesi facilitata delle nozioni fondamentali e basta. Come è credo nelle mie
corde e evidente nei
miei contributi, ho cercato di leggere le vicende
ottocentesche con uno sguardo anche alle successive conquiste novecentesche, in modo da non fare della storia un
monumento inossidabile e incrollabile ma anzi un territorio aperto dialogicamente
alle interpretazioni successive che l'estetica ha aperto da Duchamp in poi. Perché allora non raccontare la Polaroid insieme
al dagherrotipo, la carte-de visite assieme alla photomaton di Franco
Vaccari, la Contessa di Castiglione assieme a Luigi Ontani. Senza trascurare la correttezza filologica e storica degli eventi e delle
opere ma senza nemmeno isolarli in un universo fuori dal tempo e dallo
spazio.
T.B. - Una domanda anche per la presentazione al volume di Clara Carpanini:
“Vedermi alla Terza Persona” La fotografia di Claude Cahun. Nel 1974
Roland Barthes realizza: Barthes di Roland Barthes, dove si racconta in terza persona e scrive che “L’unica passione della mia vita è stata la
paura”, "paura di essere afferrato e frainteso". Una paura che
nella Cahun non si percepisce anzi, nel testo, si “legge” una continua
“rappresentazione” del proprio travestimento. A meno che non ci troviamo
davanti allo stesso “panico” ma vissuto in modo diverso.
F.M. - Sì, in un certo senso anche Claude Cahun ha paura e usa la fotografia e
l'autoritratto come antidoto alla paura di essere afferrata. Nel suo caso
il mostro da combattere e da cui fuggire è l'omologazione, lo stereotipo, la legge uguale per tutti fissata per sempre. Cahun vuole
essere un animale libero, che può rinascere ogni giorno, senza identità
predefinite, senza genere stabilito a priori.
Per raggiungere questo stato "anarchico" e libertario Cahun trova
nella fotografia una fedele alleata.
E' lì che il suo corpo androgino, il suo look lesbo, la sua anatomia antifemminile,
il suo gusto per il travestimento trovano alimento e quotidiana conferma.
La storia e l'arte di Claude Cahun credo siano uno degli esempi più avvincenti
e affascinanti proprio di quell'arte diversa delle donne pre-sessantotto
di cui si accennava sopra.
 Federica
Muzzarelli Federica
Muzzarelli
Università
di Bologna Dipartimento delle Arti Visive di Bologna
Piazzetta
G.Morandi 2
40125
Bologna
www.dav.unibo.it
www.moda.unibo.it
www.scmoda.lettere.
|

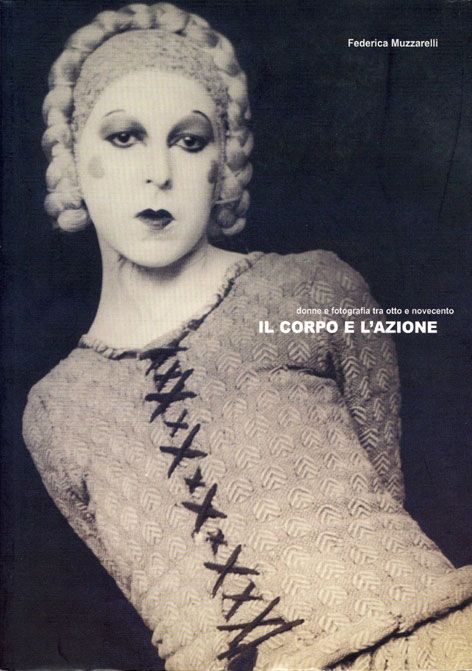
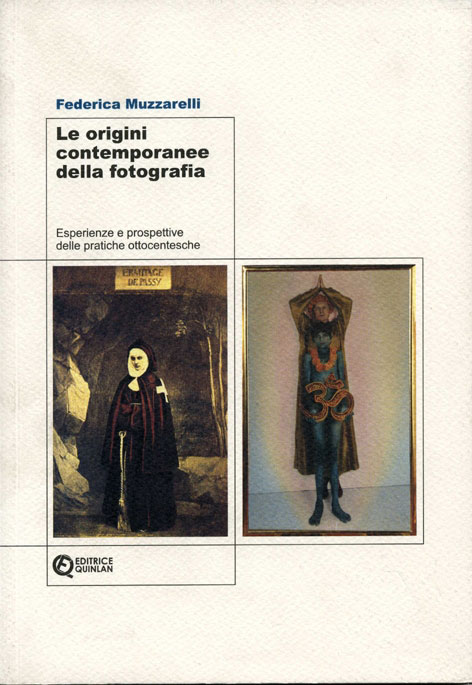
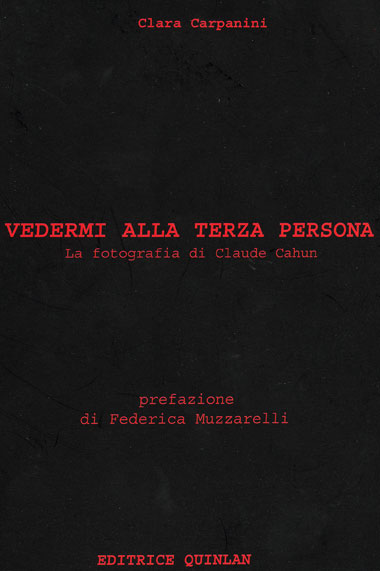
 Federica
Muzzarelli
Federica
Muzzarelli